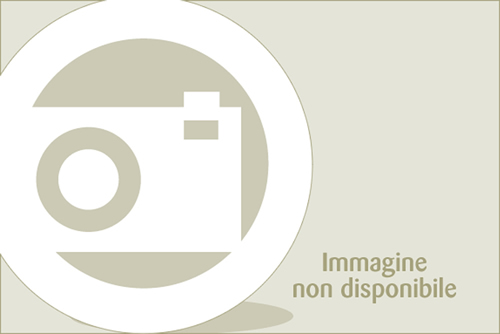DONNE NELLA GRANDE GUERRA
Teresa Labriola (Napoli, 17 febbraio 1874 – Roma, 6 febbraio 1941).
Figlia di Antonio Labriola, noto filosofo marxista, crebbe in un ambiente vivace e stimolante. Iscrittasi alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Roma, nel 1894 fu la prima donna a laurearsi in quella facoltà. Dal 1900 al 1918 ottenne la libera docenza in filosofia del diritto nel medesimo ateneo ma fallì nel tentativo di entrare nei ruoli della carriera universitaria, in gran parte a causa delle discriminazioni di genere. L'ostilità dimostratale dall'ambiente accademico in quanto donna, unita alla morte del padre che la privò di numerosi contatti all’interno dell’élite intellettuale, acuì in lei sentimenti di ribellione, che riconobbe comuni ad altre donne intellettualmente dotate e non valorizzate nella società del suo tempo, avvicinandola al movimento femminista. Nei primi anni la sua militanza si concretizzò attraverso conferenze, saggi e articoli sul tema del diritto alla rappresentanza politica e sulla condizione della donna nella società, tuttavia dal 1906 iniziò a militare attivamente nel movimento suffragista. Fin da subito il suo femminismo si contraddistinse per la vicinanza all’ideologia nazionalista, tanto che il sostegno da lei offerto alla campagna di Libia nel 1911, attirò le aspre critiche delle femministe legate ad Anna Kuliscioff. Convinta che il movimento femminista dovesse perseguire precisi scopi politici, nell'aprile del 1911 l'organismo nazionale suffragista si riorganizzò nella Federazione nazionale dei comitati pro suffragio femminile. La svolta nella maturazione politica della Labriola si ebbe con lo scoppio della Grande Guerra e la conseguente divisione tra neutralismo e interventismo anche all’interno del movimento suffragista. La Labriola si schierò a favore dell’intervento interpretando in chiave mazziniana il dovere delle donne di partecipare al destino della patria. Durante la neutralità entrò nella direzione del Comitato nazionale per l'intervento italiano e nel dicembre 1916 aderì al Comitato nazionale femminile interventista antitedesco. Secondo la Labriola le donne erano complementari allo sforzo bellico fornendo prova di patriottismo, operosità e capacità, guadagnandosi così il diritto alla loro liberazione e redenzione. Il distacco dal movimento femminista democratico si acuì nell’agosto 1917 quando respinse la mozione di “una pace senza vincitori né vinti” proposta dalle suffragiste austriache, difendendo le ragioni morali e politiche della guerra. Nello stesso anno fondò la Lega patriottica femminile legata all'Associazione nazionalista italiana, modificando radicalmente le idee originarie e, in contrasto con le suffragiste "ugualitarie", chiedeva che il diritto di rappresentanza fosse riconosciuto esclusivamente alle donne "migliori", ovvero le più affidabili sotto il profilo nazionale e patriottico. Nel dopoguerra aderì al fascismo rimanendo legata al regime fino alla morte, avvenuta a Roma nel 1941.
Edith Cavell (Swardeston, 4 dicembre 1865 – Schaerbeek 12 ottobre 1915).
Nacque in una famiglia di modeste condizioni, il padre era Vicario della chiesa anglicana, la madre casalinga e figlia di una governante. Edith iniziò gli studi privatamente, a casa, e nel 1881 passò alcuni mesi presso la Norwich High School; dai sedici ai diciannove anni frequentò altre tre scuole, a Bushey Clevedon e Peterborough, occupandosi nel frattempo come governante in diverse case private. Avendo mostrato una certa predisposizione alla lingua francese, nel 1890 ottenne un posto di lavoro come governante presso una famiglia di Bruxelles, dove rimase cinque anni. Nel 1895 tornò a casa per accudire il padre durante un breve periodo di malattia: ciò la convinse ad intraprendere la carriera di infermiera, e dopo alcuni mesi al Fountains Fever Hospital di Tooting, nell'aprile 1896 entrò in addestramento al London Hospital. Intrapresa con successo la carriera infermieristica la Cavell si recò a Bruxelles su invito del Dottor Antoine Depage, intenzionato ad innovare il settore infermieristico in Belgio. Insieme, nell’ottobre del 1907, fondarono L'École Belge d'Infirmières Diplômées, che dopo le inziali difficoltà e diffidenze ebbe grande successo. Lo scoppio del Primo conflitto mondiale la trovò in Inghilterra in visita alla madre. Ritenendo di essere più utile al fronte decise di rientrare in Belgio, pochi giorni prima dell’invasione tedesca. Decisa a restare a Bruxelles malgrado l’occupazione della città da parte delle truppe germaniche, convertì la clinica in ospedale della Croce Rossa, curando sia soldati alleati che tedeschi, fatto che le permise di rimanere malgrado fosse di nazionalità britannica. Tuttavia, per un anno circa, oltre che prendersi cura dei malati, la Cavell diede vita ad una rete di contatti che permetteva ai militari alleati dispersi dietro le linee nemiche o rimasti tagliati fuori dai propri reparti, di fuggire nei Paesi Bassi per poi fare ritorno in patria. Tra giugno e agosto 1915 la rete fu scoperta dei tedeschi che incarcerarono la Cavell con l’accusa di spionaggio, reato punibile con la fucilazione. Malgrado la mobilitazione delle autorità dei paesi neutrali, e l’intervento dell’ambasciatore statunitense in Belgio che si propose come difensore dell’infermiera nel processo, la Cavell fu condannata a morte e fucilata il 12 ottobre del 1915 nel poligono di tiro di Schaerbeek. L’esecuzione dell’infermiera scandalizzò enormemente l'opinione pubblica mondiale. Divenuta martire della causa alleata, la sua immagine fu ampiamente usata dalla propaganda per presentare una guerra dove alla violenza e alle barbarie della Kultur tedesca si opponevano gli ideali di democrazia e civiltà dello schieramento alleato.
Marija Leont'evna Bočkarëva (Nikolsky, 8 luglio 1889 – Krasnojarsk, 16 maggio 1920).
Di origine contadina, figlia di un ex servo della gleba che aveva combattuto nella guerra russo-turca del 1878 guadagnandosi i gradi di sergente, Marija Bočkarëva crebbe a Tomsk, in Siberia, dove non frequentò nessuna scuola e lavorò sin da bambina. Fervente nazionalista, allo scoppio della Prima guerra mondiale la Bočkarëva tentò senza successo di arruolarsi nell’esercito. Tuttavia, nel novembre del 1914, grazie ad una speciale concessione dello Zar riuscì ad ottenere l’arruolamento nell’Esercito. Inizialmente fu trattata duramente dai compagni d’armi, ma affrontando il combattimento e le privazioni della vita di trincea la Bočkarëva riuscì rapidamente a farsi accettare dalla comunità militare. Ferita quattro volte e decorata in tre diverse occasioni per il coraggio dimostrato, nel marzo del 1917 - dopo la caduta dello Zar e l’instaurazione del governo provvisorio - il presidente della Duma Rodzjanko le affidò l’incarico di creare un’unità di combattimento femminile detta “Battaglione femminile della morte”. Il fatto destò uno scalpore tale che la suffragetta inglese Emmeline Pankhurst partì alla volta di Pietroburgo per offrire il proprio appoggio alla Bočkarëva. Delle circa 2000 volontarie che accorsero ad arruolarsi riuscirono a completare l’addestramento solo trecento. Nel giugno 1917 la Bočkarëva e la sua unità venne inviato al fronte per l’offensiva di Kerenskij, riscuotendo alcuni successi. Tuttavia una parte delle truppe - tra le quali erano diffusi sentimenti filobolscevichi e timorose che i successi del battaglione femminile innescassero rappresaglie da parte degli austro-tedeschi – costrinse la Bočkarëva a sciogliere la sua unità. Interessante a questo scopo la testimonianza dell'infermiera inglese Florence Farmborough, nel cui ospedale da campo furono ricoverate alcune delle donne ferite: «A onore di queste volontarie è ormai scritto nel libro della storia che esse sono andate all'assalto, sono uscite dalle trincee. Ma non tutte. Alcune sono rimaste nelle trincee, svenute o in preda ad attacchi isterici; altre sono fuggite di corsa, oppure strisciando, verso le retrovie. La Bočkarëva si è ritirata con il suo battaglione decimato. Era furibonda, straziata, ma aveva appreso una grande verità: le donne non sono adatte a fare il soldato.» All’inizio del 1918 le fu affidata la missione di stabilire un contatto con il generale Kornilov, comandante dell’Armata bianca nel Caucaso. Arrestata dai bolscevichi ma rimessa in libertà, nell’aprile del 1918 partì per gli Stati Uniti, dove fu aiutata dalla femminista Florence Harriman e dettò a Isaac Don Levine le sue memorie: Yashka: My Life As Peasant, Exile, and Soldier. Trovati i fondi necessari per tornare in Russia nell’agosto del 1918, sbarcata, tentò senza successo di organizzare ad Arcangelo un nuova forza militare, unendosi poi alle truppe bianche dell’ammiraglio Kolčak. Nuovamente catturata dai Bolscevichi, fu processata e condannata a morte per attività controrivoluzionaria. La prima soldatessa russa fu fucilata il 16 maggio 1920.