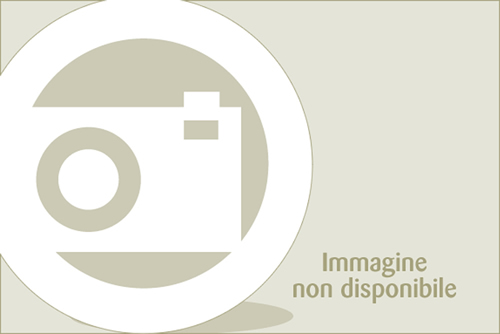23 marzo 1944, L'ATTENTATO DI VIA RASELLA
Quel giorno un gruppo di «gappisti» (i GAP, Gruppi di Azione Patriottica, erano sorti dopo il 18 settembre 1943, in prevalenza per iniziativa del PCI) aveva avuto l’ordine di predisporre un attacco contro i tedeschi del Polizeiregiment 'Bozen' che quotidianamente montavano la guardia al Quirinale, passando in assetto da guerra su per via Rasella. Erano volontari altoatesini arrivati recentemente a Roma da Bolzano e aggregati come sussidiari alle SS.
Questo compito venne affidato nelle mani di Franco Calamandrei, Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Alfio Marchini e altri 13 partigiani; il calcolo dei tempi venne ripetuto decine di volte: una bomba sarebbe dovuta esplodere quando il reparto tedesco fosse giunto a metà della strada.
I gappisti dovettero attendere circa due ore in più rispetto alla consueta ora di transito della compagnia nella via; il giovedì 23 marzo 1944 i soldati del "Bozen" erano partiti in ritardo dopo l'esercitazione di tiro effettuata al poligono di Tor di Quinto e solo alle ore 15:45 la colonna sbucò da Largo Tritone e girò verso via Rasella; fu proprio in quel frangente che avvenne l'esplosione. Tentadue di loro morirono sul colpo anche a causa delle bombe a mano che avevano alla cintola, che a causa dell'esplosione gli scoppiarono addosso, dieci restano feriti, e morirono anche due civili, che si trovarono nel posto sbagliato nel momento sbagliato nonostante tutte le precauzioni prese dai gappisti. Subito dopo l'esplosione alcuni gappisti lanciarono quattro bombe a mano (delle quali una rimase inesplosa). Dopo il lancio delle bombe a mano, i gappisti Raoul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Curreli e Pasquale Balsamo impegnarono i tedeschi in uno scontro a fuoco, mentre Capponi e Bentivegna si misero in salvo. Nessuno dei gappisti partecipanti all'azione fu ferito o fatto prigioniero dai tedeschi e si ritrovarono tutti in piazza Vittorio, dove li attendeva Carlo Salinari (responsabile dei GAP centrali).
I soldati superstiti, credendo che le bombe fossero state lanciate dall'alto, risposero sparando a lungo (anche dopo che i partigiani si erano già dileguati) contro i piani elevati degli edifici circostanti, soprattutto verso le finestre sovrastanti i negozietti all'angolo di via del Boccaccio, facendo 4 morti e 11 feriti.
La strada era disseminata di cadaveri. I feriti si trascinavano, gridando e lamentandosi, fra le pozze di sangue. Gli uomini della milizia fascista spararono all’impazzata, dentro le finestre aperte, finché Buffarini-Guidi non li fece smettere. Soldati tedeschi e poliziotti sbarrarono gli accessi a via Rasella. Fece la sua apparizione il comandante militare della città, generale Maeltzer, sbronzo come gli accadeva il più delle volte.
Dietro suo ordine, militari e poliziotti di vari corpi fecero irruzione nelle case di via Rasella e ne cacciarono fuori gli inquilini, spingendoli con i calci dei fucili.
I superstiti del "Bozen", coadiuvati da altre forze tedesche e fasciste affluite sul posto (tra cui uomini del Battaglione "Barbarigo" della Xª Flottiglia MAS), iniziarono a rastrellare la popolazione della zona circostante, arrestando abitanti e passanti; i rastrellati furono allineati sotto la minaccia delle armi contro la cancellata di accesso a Palazzo Barberini e quindi condotti in parte presso l'intendenza della PAI, in parte presso il palazzo del Viminale. In particolare, nelle cantine del Viminale furono ammassate circa trecento persone e trattenute per accertamenti sino alla mattina successiva; dieci di questo gruppo furono poi uccisi alle Fosse Ardeatine.
Maeltzer avrebbe voluto far fucilare con procedimento sommario queste persone totalmente estranee all’attentato. E Moellhausen riferisce che quando gli si accostò per indurlo alla ragione, "il re di Roma" si dichiarò deciso a far saltare in aria l’intero isolato. Fra il diplomatico e il generale scoppiò un’accesa discussione. Ma non sarà nessuno dei due a stabilire le rappresaglie. La decisione spetta a Rastenburg, o per dir meglio allo stesso Hitler, il quale dispose che se ne occupassero le SS, dacché anche le vittime appartenevano ai loro ranghi (il che non è del tutto esatto).
Fra il pomeriggio del 23 e la mattina del 24 varie bande fasciste arrestarono nei quartieri del ghetto numerosi ebrei, che furono incarcerati a Regina Coeli per poi essere uccisi (assieme ad altri ebrei che erano già prigionieri al momento dell'attentato) alle Fosse Ardeatine. Secondo Anna Foa, il fatto che molti di costoro siano stati arrestati per strada o nelle proprie case conferma che la rappresaglia non fu preceduta da nessun avviso, e indica forse che la notizia dell'attentato «non fu subito diffusa in tutta la città, perché altrimenti avrebbe certo messo in allarme gli ebrei nella loro semiclandestinità».
Il primo a comunicare telefonicamente la notizia dell’attentato a Mussolini è il prefetto di Salerno. Dopo di lui gli parlò Buffarini-Guidi, che si era recato allora sul luogo dell’attentato e gli fornì particolari della reazione immediata di Maeltzer, «ubriaco come al solito e talmente fuori di sé da voler far saltare in aria, con un paio di cariche esplosive, tutto un isolato di case d’abitazione.» Alla domanda di Mussolini se avesse già sentito qualcosa a proposito delle immancabili rappresaglie, Buffarin gli rispose di no, tranne che a detta di Maeltzer sarebbero state terribili e immediate.
Mezz’ora dopo Buffarini, che si era impegnato a tenerlo al corrente, lo richiamò per dirgli di aver appreso in quel momento da Caruso, il questore di Roma, che la vendetta dei tedeschi sarebbe stata spaventevole: dieci italiani per ogni soldato rimasto ucciso. E aggiunge che secondo lui l’ordine era stato impartito dal Führer. Mussolini commentò sfavorevolmente la decisione, perché avrebbe soltanto peggiorato ulteriormente la situazione e lo informò di aver già protestato con Rahn e con Wolff, scongiurandoli di desistere da reazioni cruente. Buffarini gli chiese se fosse riuscito a ottenere qualcosa. Rahn, a detta di Mussolini, pur condividendo il suo parere non aveva il potere d’interferire nella questione e quanto a Wolff, benché al colmo dell’ira, avrebbe ordinato a Kappler di non prendere iniziative fino all’indomani, quando lui, Rahn, sarebbe arrivato a Roma.
In seguito da molte parti sono state levate critiche contro gli attentatori, poiché l’azione non ottenne lo scopo che si erano proposti: portare a un tale inasprimento delle misure terroristiche da parte dell’occupante, da spingere tutta Roma a un’insurrezione di massa contro i tedeschi, guidata dal movimento comunista clandestino. Ma l’insurrezione non vi fu.
L'azione partigiana indusse inoltre i tedeschi a intensificare le misure per la sicurezza delle truppe. Lo stesso 23 marzo, alle truppe dipendenti dal comandante supremo del sud-ovest fu ordinato: «In futuro nelle località maggiori si dovrà marciare soltanto in ordine sparso, con adeguata protezione alla testa, alle spalle e ai fianchi».
D'altro canto l'azione ebbe effetti positivi sul morale delle forze della Resistenza e sul morale degli Alleati, i quali rimasero positivamente colpiti dallo scacco subito dai tedeschi da parte dei GAP, e la notizia sollevò anche le truppe alleate sul fronte di Cassino, che si resero conto di combattere una guerra 'assieme' al popolo italiano. Da quel giorno in poi i tedeschi smisero di utilizzare le vie della capitale per spostare le proprie truppe, preferendo spostamenti lungo le periferie. L'ostilità dei romani all'occupazione tedesca peraltro rispecchiava quella del resto della popolazione del nord Italia, dove nella primavera del 1944 crebbero gli episodi di resistenza e azioni di sabotaggio lungo le linee tedesche, che impegnarono sempre più uomini della Wehrmacht e della RSI. A maggio i partigiani erano più di 70 000 (in confronto dei 10 000 di inizio anno) che operavano in una trentina di zone del nord; secondo Alexander, il 22 maggio i patrioti «tenevano ormai in scacco» sei divisioni tedesche. Lo stesso Kesselring dovette ammettere che durante la lotta anti-partigiana in Italia «la quota di perdite da parte tedesca è stata assai più elevata di quella delle bande», e che il grande pericolo che i partigiani rappresentavano per un'eventuale ritirata delle due armate tedesche dalla Gustav dovesse porre la lotta contro le formazioni partigiane «sullo stesso piano della guerra al fronte», con l'impiego di ogni mezzo bellico.
-VMS
Fonti bibliografiche:
- Gerhard Schreiber, 'La vendetta tedesca'
- Lutz Klinkhammer, 'L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945'
- Erich Kuby, 'Il tradimento tedesco'
Fonte fotografica: Soldati tedeschi e fascisti repubblichini mentre effettuano il rastrellamento di via Rasella poco dopo l'attentato. Bundesarchiv, Bild 101I-312-0983-03.