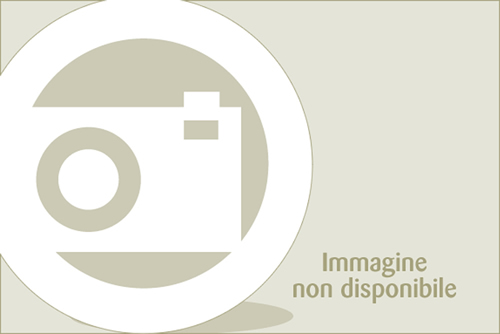Storie di uomini: la storia dimenticata di Livio Gardenghi da Castel Guelfo, uno degli uomini del tunnel di Baruzzi
La Grande Guerra è comunemente conosciuta come una guerra di posizione e di trincea, con le truppe inchiodate sui campi di battaglia in schieramenti rigidi, fissi, protette da linee su linee di opere trincerate e fortificate difficili da espugnare in cui la difesa aveva spesso la meglio sull’offesa.
Le armi automatiche dominavano il campo di battaglia e non c’era alternativa, per ora, nelle menti dei grandi strateghi e degli stati maggiori di tutti gli eserciti, al brutale e “ottuso” assalto frontale. Solo sul finire del 1916 e nel 1917 nacquero innovazioni tali da far scaturire nuove idee sul campo tattico strategico. Un nuovo utilizzo delle artiglierie e la nuova concezione d’attacco a piccoli gruppi e ad infiltrazione nelle linee avversarie, portarono a tali novità da modificare queste vecchie concezioni e a scardinare queste ripetitive metodologie di “fare la guerra”. Una delle novità più importanti fu senz’altro la creazione di reparti d’assalto per queste azioni rapide, a piccoli gruppi: le Sturmtruppen tedesche e gli arditi italiani, per fare due nomi, truppe specializzate nei colpi di mano veloci, imprevedibili e spietati, in cui coraggio e fortuna dovevano andare a braccetto nel favorire la buona riuscita dell’azione.
Questo non significa che “l’arte” dei colpi di mano fosse sconosciuta negli anni precedenti alla creazione delle truppe d’assalto: tutt’altro. Nonostante il “piattume” tattico imposto dall’incontro scioccante con la “nuova guerra”, non mancarono su tutti i fronti episodi fortunosi in cui piccoli gruppi di uomini, se non a volte addirittura singoli uomini, quasi sperduti nell’immensità e desolazione dei campi di battaglia della Grande Guerra, caratterizzati dalla famigerata terra di nessuno, sconvolta dai crateri delle granate e dal filo spinato, riuscirono di sorpresa a portare a termine azioni improbabili, sorprendenti sia agli occhi del nemico che di chi, in prima persona, vi aveva preso parte.

Fort Doaumont
Il più famoso di questi sorprendenti colpi di mano dell’intera guerra è senz’altro la presa del forte di Douaumont, a Verdun del 25 febbraio 1916. Protagonista assoluto di quest’azione il ventiquattrenne sergente del genio tedesco Kunze (non conosciamo nemmeno il suo nome di battesimo!), originario di una famiglia contadina della Turingia. Durante una fase confusa di uno dei tanti attacchi tedeschi al forte, Kunze, addetto al taglio dei reticolati di fronte al forte insieme ad una pattuglia di genieri, colse l’attimo per un’impresa folle. La piccola pattuglia, trovato un varco fra il filo spinato, inosservata ed anzi, così vicina al forte francese da essere sotto il fuoco delle artiglierie tedesche stesse, si calò nel grande fossato della poderosa fortificazione francese, passando addirittura, correndo, sotto la canna di un cannone francese intento a sparare. Con una piramide umana Kunze riuscì a raggiungere e a forzare una finestra a quattro metri di altezza e ad intrufolarsi nel forte. Qui cominciarono una serie di eventi degni di uno sketch di un film dei fratelli Marx. Rimasto con soli due uomini, che lo hanno seguito, Kunze si ritrovò dentro i corridoi bui dell’enorme forte. Seguì i rumori prodotti dalle artiglierie e le voci degli uomini francesi di guarnigione. Mise i suoi due uomini a guardia di uno snodo di corridoi e proseguì da solo all’interno della costruzione. Nel suo girovagare confuso riuscì a chiudere in una stanza stagna un gruppo di soldati francesi che lo avevano visto, evitando così che potessero dare l’allarme. Fu così che si imbatté nei locali della mensa ufficiali del forte con la tavola imbandita di uova, vino ed altre pietanze che Kunze non vedeva da molti mesi, costretto a mangiare il rancio del soldato. Fu così che Kunze si accomodò a tavola e cominciò ad ingozzarsi di cibo, senza curarsi di ciò che potesse capitargli. All’esterno del forte la battaglia volgeva a favore dei tedeschi che si avvicinavano sempre di più con le loro puntate offensive al forte. Fu così che entrarono nel forte fortunosamente anche altri nuclei di soldati tedeschi, questa volta però guidati da ufficiali: in ordine di arrivo, il tenente Radtke, il capitano Haupt e il primo sottotenente von Brandis. Mentre Kunze era ancora intento a mangiare nella mensa ufficiali, il forte cadeva completamente in mani tedesche. Morale della favola: quando venne il momento da parte dei comandi tedeschi di premiare e glorificare i conquistatori del forte, tutti si dimenticarono di come erano andate veramente le cose. Il tenente Radtke e il sergente Kunze, i primi due ad entrare nel forte, non apparvero nemmeno nei rapporti. Furono premiati solamente Haupt e, soprattutto von Brandis. Quest’ultimo fu portato in palmo di mano dai comandi: nobile (come testimonia quel “von” davanti al suo cognome) ma soprattutto un uomo che già solo nel suo aspetto incarnava la figura del “vero” soldato tedesco. Von Brandis, premiato con la croce Pour le Merite, la più alta onorificenza tedesca, fu promosso ed incensato, nonostante il suo ruolo fosse stato davvero marginale e da ultimo arrivato che non aveva fatto altro che prendere atto della caduta del forte. Già nel 1917 Cordt von
ciò che potesse capitargli. All’esterno del forte la battaglia volgeva a favore dei tedeschi che si avvicinavano sempre di più con le loro puntate offensive al forte. Fu così che entrarono nel forte fortunosamente anche altri nuclei di soldati tedeschi, questa volta però guidati da ufficiali: in ordine di arrivo, il tenente Radtke, il capitano Haupt e il primo sottotenente von Brandis. Mentre Kunze era ancora intento a mangiare nella mensa ufficiali, il forte cadeva completamente in mani tedesche. Morale della favola: quando venne il momento da parte dei comandi tedeschi di premiare e glorificare i conquistatori del forte, tutti si dimenticarono di come erano andate veramente le cose. Il tenente Radtke e il sergente Kunze, i primi due ad entrare nel forte, non apparvero nemmeno nei rapporti. Furono premiati solamente Haupt e, soprattutto von Brandis. Quest’ultimo fu portato in palmo di mano dai comandi: nobile (come testimonia quel “von” davanti al suo cognome) ma soprattutto un uomo che già solo nel suo aspetto incarnava la figura del “vero” soldato tedesco. Von Brandis, premiato con la croce Pour le Merite, la più alta onorificenza tedesca, fu promosso ed incensato, nonostante il suo ruolo fosse stato davvero marginale e da ultimo arrivato che non aveva fatto altro che prendere atto della caduta del forte. Già nel 1917 Cordt von

Cordt Von Brandis
Brandis pubblicò il proprio racconto sulla presa del forte, tutto autoriferito, tendente a sminuire anche il ruolo di Haupt, che infatti cadde presto anch’esso nel più completo anonimato. Il ruolo di von Brandis rimase indiscusso fino a dieci anni dopo la fine della guerra quando uno studio tedesco riportò alla luce la verità. Fu così che nel 1930 vennero rintracciati sia Radtke che Kunze, entrambi sopravvissuti alla guerra. Kunze faceva il poliziotto, dimenticato da tutti. Fu così che per premio ottenne una promozione a ispettore. Radtke invece ricevette dal Kronprinz una fotografia con dedica. Ben poco rispetto all’incensato von Brandis che con quelle sue onorificenze, senza dubbio, anche durante la disastrata Repubblica di Weimar, percepì indennizzi in denaro.
La storia della conquista di forte Douaumont è l’emblema del colpo di mano fortunoso tipico della Grande Guerra, soprattutto perché avvenuto nel 1916, e a Verdun, dove la guerra di posizione, di trincea e di materiali sublimò. La fortuna trova strade inaspettate ed aiutaci gli audaci, si dice, e Kunze senz’altro fu un fortunato audace che però rischiò seriamente di non essere ricordato per nulla. Era l’amaro destino che poteva essere riservato a qualunque soldato protagonista di un atto di valore: se non c’era un ufficiale che comprovava la veridicità del gesto eroico con la propria testimonianza oculare, anche il più coraggioso dei soldati poteva vedersi negato il giusto riconoscimento. Von Brandis, sicuramente, tirò acqua al suo mulino dimenticandosi astutamente di riconoscere quanto fatto da Haupt, Radtke e soprattutto Kunze.
Anche sul fronte italiano non mancarono i colpi di mano prima dell’avvento delle truppe

Aurelio Baruzzi da Lugo
d’assalto, negli anni “bui” degli assalti frontali “cadorniani”. Come non ricordare ad esempio la presa del monte Nero del 16 giugno 1916, vero e proprio fiore all’occhiello tutt’oggi delle truppe alpine italiane. Sicuramente però il colpo di mano pre-arditi più famoso di tutta la guerra italiana è la cattura da parte del sottotenente originario di Lugo Aurelio Baruzzi, classe 1897, che con soli 4 uomini catturò la guarnigione di un pericoloso presidio austriaco sul rovescio del Podgora, posto all’interno di un tunnel stradale. Il tutto avvenne all’alba dell’8 agosto 1916 nelle prime fasi della battaglia che portò il Regio Esercito alla conquista di Gorizia, la prima vera e grande vittoria delle armi italiane dopo oltre un interno anno di guerra.
Baruzzi sta assistendo al bombardamento italiano in preparazione dello sbalzo in avanti. Già diversi tentativi precedenti verso il rovescio del Podgora erano stati stroncati sul nascere. Gli austriaci apparivano all’improvviso da non si sa dove, a frotte, nonostante ore di bombardamento. Doveva esserci per forze un grande appostamento nascosto che fungeva da riparo. Baruzzi, in solitaria, durante il bombardamento e si avvicina alla linea austriaca scoprendo il sottopassaggio. Nei pressi notò un austriaco morto: la sentinella addetta a dare l’allarme ai commilitoni nascosti al sicuro sotto il grande voltone di cemento.
Tornò trafelato dal suo comandante di compagnia, il capitano Foschini. Baruzzi militava infatti nel 28° reggimento di fanteria della brigata Pavia, una delle brigate che fin dalla fine di maggio del 1915 era stata unicamente impegnata sulle posizioni del Podgora sulla testa di ponte di Gorizia. Il fronte del Podgora è tutt’oggi ricordato come un vero e proprio calvario degli emiliano-romagnoli che in quel settore schierarono ben tre brigate a componente regionale: la Pistoia (35° e 36°, i reggimenti di Bologna e Modena), la Casale (11° e 12°, i reggimenti di Forlì e Cesena) e per l’appunto la Pavia (27° e 28° i reggimenti di Rimini e Ravenna).
Lasciamo la parola direttamente a Baruzzi: “Espongo il mio desiderio [al capitano Foschini] di tentare un colpo di mano, al massimo con una ventina di uomini. [-] – Non più di dieci volontari – approva il capitano conscio delle gravi perdite che già erano costati i vani attacchi al sottopassaggio. [-] Da recenti notizie si ritiene che il sottopassaggio sia attualmente occupato da settanta-ottanta uomini. Certo, per tentarvi un colpo di mano, una decina di fanti sono veramente pochi, anche se decisi a tutto. Ma, pur di togliere di mezzo quel grave ostacolo che da ben due giorni ci impedisce di raggiungere i ponti di Lucinico e l’Isonzo e la cui occupazione avrebbe richiesto – in un secondo tempo- sacrifici di sangue molto maggiori, valeva ben la pena di tentare. Calcolo altresì di trovarmi di fronte un nemico stanco, sottoposto da ben 48 ore a continui bombardamenti e attacchi, benchè il sottopassaggio offra un ottimo sicuro riparo contro i tiri della nostra artiglieria anche di grosso calibro.
Avevo già il mio piano preparato: partendo dal presupposto che le truppe che presidiano il sottopassaggio, se attaccate, si difenderebbero come nei due giorni precedenti, ma se circondate si arrenderebbero, debbo fare in modo che, bluffando, gli occupanti del sottopassaggio – il cui ingresso è in gran parte ostruito da quel traversone che ho notato durante la mia esplorazione e che ne ostacola la vista dall’interno all’esterno- ritengano di essere effettivamente circondati qualora io dia loro l’impressione di avere molta truppa al mio seguito.
Poiché la compagnia è tutta schierata su un fronte piuttosto vasto, riesco sul momento a trovare quattro soli volontari, tra i quali il caporal maggiore Gardenghi, delle mie parti di Romagna. D’altronde occorre fare presto prima che sia giorno fatto e soprattutto perché il nemico non si accorga della morte della sentinella”.

Livio Gardenghi da Castel Guelfo, compagno di Aurelio Baruzzi nell’impresa del tunnel
Ed eccolo qua appena citato il protagonista di questo articolo: un “Kunze italiano”, il caporale maggiore Livio Gardenghi, compagno dell’impresa di Baruzzi nel famigerato tunnel. Come abbiamo appena visto Baruzzi non ricorda altri nomi se non quello di Gardenghi. È un altro memorialista della Pavia che ci ricorda anche i nomi di altri componenti del quintetto. Si tratta del capitano Bongiorno Tasca che a tal proposito scrive: “Cinque risposero: – io! – Erano il Baruzzi e i soldati De Antoni Innocente, Gardenghi Livio, Croce Tobia e un altro”. Sappiamo così i nomi di tre dei quattro che seguirono Baruzzi. Di uno, purtroppo, nulla si sa. Né De Antoni né Croce appaiono negli attuali database dei caduti italiani della Grande Guerra che forniscono i dati anagrafici di ogni morto: di loro possiamo quindi dire che sappiamo con certezza che, oltre alla fortuna di scampare all’impresa del tunnel, riuscirono a sopravvivere al conflitto. Solo di De Antoni, con una ricerca sul database dei decorati, sappiamo che era originario di Sacile. Leggermente diverso il discorso per Gardenghi.
È lo stesso Baruzzi a fornirci qualche piccolo dettaglio di lui dicendo: “dalle mia parti di Romagna”. Ma Gardenghi non era esattamente un romagnolo. Sempre grazie ad una ricerca sul database dei decorati scopriamo che Livio Gardenghi era originario di Castel Guelfo, in provincia di Bologna. Una ricerca fra i cimiteri nei dintorni di Castel Guelfo ha permesso di saperne di più Livio Gardenghi era classe 1888. Aveva quindi 9 anni in più di Baruzzi. Non era raro che dei giovanissimi sottotenenti si trovassero a comandare uomini anche molto più anziani di loro, che spesso potevano addirittura essergli anagraficamente padri.
Gardenghi ha la fortuna, a differenza di Kunze, di non avere in Baruzzi un von Brandis che lo ignora nelle sue ricostruzioni. Anzi, leggendo ancora la testimonianza scritta del lughese vediamo come il suo nome sia l’unico riportato e l’unico con il quale imbastisce durante l’impresa diversi brevi dialoghi “organizzativi”. Sentiamolo ancora: “Faccio subito rifornire di bombe i miei quattro uomini, raccogliendole dagli altri fanti, avvertendoli di dare la preferenza ai petardi Thevenot: benché procurino normalmente soltanto leggere ferite, hanno però il pregio di provocare un forte effetto demoralizzante sul nemico, dovuto al loro potente scoppio, che avviene a percussione sul terreno, e al gran fumaccio che producono. – Signor tenente, i Thevenot fanno soltanto un gran fracasso e molto fumo, ma non accoppano nessuno – mi fa notare Gardenghi. – Non ho intenzione di fare una strage, ma soltanto di occupare il sottopassaggio! E poi dovranno servire soltanto in caso di estrema necessità. […] – Quel maledetto sottopassaggio…! Fortuna gli audaci aiuta, e… non si può mai sapere. In bocca al lupo e… prudenza”. E così i cinque si avviano verso il sottopassaggio mentre l’artiglieria italiana continua a battere la zona. Continua Baruzzi: “Il nemico, ora che sta sparando la nostra artiglieria, non sospetta affatto una nostra sorpresa e se ne sta tranquillo fidando nella sorveglianza dell’uomo posto a sentinella. […] Il caporale maggiore Gardenghi, il quale ha seguito il mio sguardo rivolto verso il fondo del camminamento, mi guarda con aria interrogativa, poi – Signor tenente, esclama, siamo soltanto quattro, che facciamo? – Tentiamo ugualmente!
È così che i cinque piombano nel bel mezzo del tunnel. Baruzzi intima la resa simulando di essere la punta avanzata di un reparto italiano al completo. A forza di tedesco stentato e di esclamazioni in romagnolo, di “boia d’un mond lèdar!” e “a stet ferum!”, Baruzzi riesce a controllare la situazione. SI consegnano a lui oltre 200 uomini. Tutta l’azione è durata pochissimo, un vero e proprio colpo di mano. “Quanto tempo è passato dal mio ingresso al sottopassaggio? Tutto si è svolto così velocemente che ritengo siano trascorsi poco più di 5 minuti, o al massimo 10.” La dea bendata e il coraggio glaciale dei cinque fece sì che l’azione avesse successo.

Visuale odierna del tunnel di Baruzzi
Questo episodio rimane ancora oggi uno dei più conclamati della guerra. Nessuno degli addetti ai lavori non lo conosce. Baruzzi fu premiato con la medaglia d’oro al valor militare, che gli venne consegnata con una cerimonia solenne nelle primissime retrovie direttamente dal Duca d’Aosta. Dal database dei decorati, come abbiamo visto, vediamo come sia Gardenghi che De Antoni siano stati insigniti a loro volta della medaglia d’argento. Di Tobia Croce e soprattutto dell’altro soldato… nessuna traccia: dei veri e propri Kunze italiani. Certamente anche di Livio Gardenghi, al di là dell’onorificenza, sappiamo ben poco. All’anonimo sergente della Turingia lo accomuna una sorta di progressivo oblio che oggi lo porta ad essere un autentico sconosciuto. Nemmeno sulla tomba Gardenghi ha voluto ricordare le sue gesta, come invece hanno fatto tanti altri reduci: nessuna traccia delle sue onorificenze. Livio Gardenghi difatti non guadagnò solo quella medaglia. Dal suo foglio matricolare ricaviamo altri dati interessanti sulla sua storia. Nel 1909 fu dispensato dal servizio militare per “deficienza di statura”. Il suo metro e 56 di altezza non bastavano a farne un soldato. Nel 1915, alla mobilitazione generale, man mano, a queste sottigliezze non si fece più caso. Non è la prima volta che si leggono storie di soldati, autentici fegatacci, alcuni addirittura arditi, che vennero rifiutati alle visite mediche e che dovettero pregare, taluni, di essere arruolati, tanto era lo spirito combattivo che li pervadeva. Livio Gardenghi, figlio di Luigi e di Anna Bertocchi, era da poco rientrato in Italia dopo essere emigrato in Svizzera nel 1911 per cercare lavoro. Venne richiamato il 9 maggio 1915 in servizio nel 28° Pavia, con cui rimase fino al marzo 1917. Nelle note caratteristiche del suo foglio matricolare, oltre alla “deficienza di statura”, possiamo vedere come fosse di estrazione umile e contadina e che dichiarasse di non saper né leggere né scrivere. Un tipico soldato italiano della Grande Guerra.

Una foto austriaca dell’interno del tunnel
Con la Pavia combatté sul Podgora per tutto il 1915 e fino ad agosto 1916, fino a quando, per l’appunto, partecipò con Baruzzi ad uno dei momenti chiave della caduta della testa di ponte di Gorizia. Con “i verdi” (così erano chiamati i fanti della Pavia per il colore delle mostrine, combatté anche a Vertojba, nell’infame pantano di questa zona palustre a est di Gorizia che fermò l’avanzata italiana che invece era sembrata così promettente dopo la caduta della città.
Qui Gardenghi Fra il 10 e il 13 ottobre, durante la ottava battaglia dell’Isonzo, guadagnò una seconda onorificenza, questa volta di bronzo, con la seguente motivazione: “All’ordine dell’attacco, risolutamente lanciavasi contro le trincee nemiche incitando i compagni col grido di – Avanti! Avanti! – e a seguirlo nell’attacco. Durante tre consecutive giornate di combattimento fu nobile esempio ai compagni, cui il suo contegno trasfondeva la fede nella sicura vittoria”. Nel marzo 1917 Gardenghi viene trasferito al 255° reggimento fanteria della brigata Veneto, il reggimento di cui era il cappellano don Minzoni. L’esperienza di guerra del 255° nel 1917 è molto poco gratificante: carso di Monfalcone, zona di Flondar, davanti all’imprendibile bastione dell’Hermada. Poi il ripiegamento sul Piave, dove, nella battaglia del solstizio, in zona Candelù, meritò un’altra medaglia, di nuovo d’argento, con questa motivazione: “Rimasta in mano del nemico una parte della propria sezione pistole mitragliatrici, compreso il comandante, riuniva i superstiti e, con irruento contrattacco riusciva a rioccupare la trincea, recuperando le armi ed infliggendo perdite all’avversario”. Una motivazione che ci permette di collocare Gardenghi nella sezione pistole mitragliatrici Villar Perosa del 255°.

Il servizio militare di Gardenghi finì nel febbraio 1919, dopo tre anni e 9 mesi dal richiamo. Tornò quindi nella sua Castel Guelfo con tre medaglie al valore sul petto. Non sappiamo quasi nulla della sua vita dopo la guerra. Sicuramente si sposò con Luigia Solaroli, di 4 anni più giovane di lui e con la quale oggi condivide la sepoltura nel cimitero di Castel San Pietro Terme. Con i coniugi Gardenghi riposano anche le due figlie, Nerina e Doriana, recentemente scomparse. Livio Gardenghi morì a 61 anni nel 1949, lasciando la moglie vedova fino al 1971.

Il foglio matricolare di Livio Gardenghi (Archivio di Stato Bologna)
Con questo articolo ho provato a rispolverare la sua storia dimenticata per non renderlo un “Kunze italiano” e per far ricordare a questo paese che mai come oggi ha bisogno di esempi di rettitudine, di cosa furono capaci i nostri avi, anche i più umili, animati da senso del dovere e dal rispetto. Di uomini così, purtroppo, oggi, ne esistono sempre meno.

Un estratto dal fumetto: “Primo a Gorizia” dal Corrierino dei Piccoli n° 12 del 22 marzo 1970 che racconta in 7 pagine l’impresa del tunnel di Baruzzi con grande fedeltà al racconto originale. I disegni sono di Sergio Toppi e la sceneggiatura di Mino Milani (che firma con lo pseudonimo Eugenio Ventura). In varie vignette sono riportati i dialoghi originali di Baruzzi con Gardenghi.