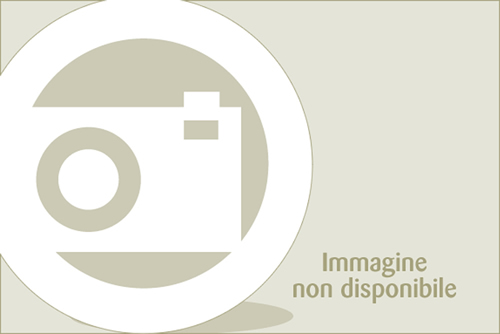FIGURE DI COMBATTENTI: VINCENZO IERACI
Vincenzo Ieraci, il giorno 2 Giugno u.s. ha ricevuto a Catanzaro la Medaglia di Internato Militare che è stata ritirata dal figlio Enrico.
Pubblichiamo la sua storia
Nasce il 22.10.1917 a Zagarise (CZ) un piccolo paesino della presila catanzarese, ultimo di una famiglia numerosa, tre fratelli e quattro sorelle.
Viene chiamato alle armi in data 25.05.1938, ed incorporato al Deposito misto Guardia alla Frontiera del 2° Corpo d’Armata, 29.05.1938 viene aggregato, per addestramento al 33° RGT Fanteria.
In data 11.08.1938, passa effettivo al 7° RGT deposito misto Guardia alla Frontiera, per un breve periodo, ed il 17.08.1938 rientra al corpo.
In data 15.03.1939, opera nel III Settore di copertura, in data 01.07.1939, opera invece nel IV Settore di copertura.
In data 25.11.1939, riceve comunicazione che verrà trattenuto alle armi, non può congedarsi, la Guerra è vicina; in data 03.12.1939 viene inviato in licenza straordinaria di gg.30, per salutare la sua terra i suoi affetti, chissà quando ritornerà e se ritornerà.
Il 10.06.1940, dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, il Duce annuncia l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dei tedeschi. Ma l’Italia non è pronta, non ha le industrie belliche tedesche, non ha i mezzi, l’equipaggiamento adatto, le armi sono obsolete. Si sta ancora riprendendo dalle guerre coloniali, dall’Albania. Ha il cuore dei propri soldati, il loro onore, il loro spirito di sacrificio, la loro fede, ma…
In data 11.06.1940, opera presso il IV Settore di copertura mobilitato, dichiarato territorio in Stato di Guerra e partecipa attivamente a tutte le operazioni sul fronte alpino orientale.
Il 24.11.1940, viene trasferito al 18°RGT Fanteria – Divisione “Acqui” con sede in Merano (BZ) vicino al confine austriaco.
Il 18°RGT Fanteria è appena rientrato dal fronte Alpino Occidentale, ove ha combattuto contro la Francia e riceve subito l’ordine di portarsi sul Fronte Greco/Albanese; in data 11.12.1940 si imbarca per l’Albania dal porto di Bari, giunge a Valona (Albania) il 15.12.1940.
Nel corso della seconda guerra mondiale, Corfù fu occupata dall'Esercito Italiano nell'aprile 1941. Tale occupazione durò fino al settembre 1943: durante questo periodo, sempre insieme alle Isole Ionie, venne amministrata come entità separata rispetto alla Grecia con l'intento di prepararne l'annessione al regno d'Italia, valendosi dell'appoggio dei Corfioti italiani.
In data 08.12.1941, viene ricoverato all’ospedale da campo n. 582, dimesso il 16.12.1941. Il 03.03.1942, viene ricoverato all’ospedale da campo n.39, il 13.03.1942 viene trasferito all’ospedale da campo n. 924, il 23.03.1942 viene dimesso e rientra al corpo.
Fino all’ 08.09.1943 partecipa a tutte le operazioni attive nel settore dei Balcani con il 18°RGT Fanteria.
A Corfù vi sono circa 4.000 soldati italiani. Il grosso è costituito appunto dal 18°RGT Fanteria, appartenente alla Divisione Acqui; vi sono inoltre una Compagnia Mitraglieri, un Battaglione Mortai, una Compagnia Cannoni, Contraerea, Carabinieri, Guardia di Finanza, Genio, Sussistenza, Trasmissioni, Sanità. La Marina è rappresentata da una flottiglia di dragamine. Vi è un distaccamento dell'Aeronautica in servizio all'aeroporto di Garitsa.
Diversamente dalle vicende di Cefalonia, il Comando italiano sull’isola, retto dal Colonnello Lusignani, riesce a mantenere i collegamenti con l'Italia. Dopo l’annuncio dell’armistizio dell’08.09.1943, il giorno 11 riceve due telegrammi dal Comando tattico di Francavilla Fontana, (BR – Puglia) in cui si chiede "Opponetevi con forza at qualsiasi tentativo sbarco reparti germanici"; "Provvedete immediata cattura elementi tedeschi considerandoli prigionieri di guerra", ambedue firmati dal Generale Mario Arisio.
A Corfù, al momento dell'armistizio, vi sono pochi soldati tedeschi, non più di 450 uomini, secondo fonti italiane, ma secondo lo storico tedesco Schreiber anche meno, ovvero circa 100 specialisti dell'Aviazione militare, 30 uomini del Comando Aeronautico di presidio e 20 militari del 313°BTG di pionieri di marina. Questi soldati, vengono immediatamente fatti prigionieri dagli italiani e saranno prelevati da navi britanniche il 23 settembre e condotti quali prigionieri in Africa Settentrionale. Le comunicazioni tra Corfù e i comandi tedeschi di Giannina e di Salonicco (nella parte settentrionale della Grecia) sono interrotti già dal giorno 8 settembre.
L'11 settembre giunge sull'isola il Capitano Spindler per intavolare trattative col Colonnello Lusignani, comandante del 18°RGT Fanteria della divisione “Acqui”, che rifiuta di cedere le armi, non avendo avuto disposizioni a riguardo dai propri superiori. Ugualmente infruttuosa si rivela la missione del maggiore Hirschfeld, che il giorno successivo riesce a raggiungere via mare Corfù, dopo essere stato costretto a tornare indietro col suo aereo per il fuoco della contraerea italiana. A sera Hirschfeld comunica che: "Il Comandante, dallo stile asciutto e conciso, non è assolutamente disposto a trattare. Lo Stato Maggiore orientato in modo totalmente ostile verso i tedeschi". Un ultimo tentativo per assumere pacificamente il controllo dell'isola è intrapreso il giorno 13, quando la richiesta di cedere le armi viene consegnata al superiore di settore di Lusignani, il Generale Guido Della Bona, Comandante del XXVI Corpo d'Armata Italiano, che aveva deposto le armi già alle ore 18.00 del 9 settembre. Nel suo messaggio a Lusignani, Della Bona si esprime così: "Alle ore 18 del giorno 9 corrente ho in Giannina deposto le armi per evitare inutile spargimento di sangue. Il corpo d'armata è inviato in Albania per essere avviato in Italia. Ad evitare spargimento di sangue in Corfù potete se del caso regolarvi di conseguenza". Alle 7.00 del 13 settembre Hirschfeld torna di nuovo a Corfù, mentre un reparto da sbarco della 1^ Divisione da Montagna, su 13 imbarcazioni, si prepara a prendere terra, fidando sulla sorpresa, nei pressi del capoluogo. Alle 12.05 giunge però il comunicato del Maggiore sul rifiuto del Colonnello Lusignani di arrendersi; lo sbarco viene ugualmente tentato, con l'appoggio di nove bombardieri Ju-87. La risposta della difesa costiera italiana è però efficace. Un aereo e un mezzo da sbarco sono colpiti. Altri mezzi sono danneggiati. Alle 18.45 il reparto rientra a Igumenitza, ma è chiaro che le forze a disposizione non sono in grado di penetrare le difese italiane. Già la sera del 12, intanto, su richiesta dei rappresentanti dell'EAM (Ethniko Apeleftherotiko Metopo – Fronte di liberazione Nazionale, Lo scopo del movimento fu di organizzare in Grecia una rete di resistenza contro le forze di occupazione tedesche, italiane e bulgare) sono liberati circa 500 detenuti politici rinchiusi nel campo di concentramento del Lazzaretto, molti sono vecchi dirigenti dei partiti antifascisti trasferiti dal continente. Il giorno 13 iniziano a sbarcare a Corfù, in vari gruppi, i soldati del 3°BTG del 40°RGT Fanteria della Divisione “Parma”, al comando del Colonnello Elio Bettini, provenienti da Porto Edda (Santi Quaranta - Albania), sul continente, in totale circa 1.000 uomini. I tentativi di sbarco tedeschi, sempre respinti, continuano il 14 e il 15, mentre quasi ogni giorno vi sono bombardamenti ad opera del X Corpo Aereo. Il Generale Lanz, nonostante il colpo subito, decide di riprovare, con forze raddoppiate e dopo un massiccio intervento aereo sulle postazioni italiane avviato già nel corso della notte. L'attacco finale però è spostato di qualche giorno, la preparazione richiede più tempo, si pensa di fissare l'inizio dell'operazione per la notte tra il 16 e il 17 settembre, ma poi la data continua a scivolare in avanti, mentre da Cefalonia, dopo le prime confortanti comunicazioni di Barge, che ancora il 12 prevedeva una rapida soluzione della crisi, giungono notizie sempre più preoccupanti, in particolare con l'incidente del 13, quando due motozattere tedesche (che dovevano portare solo viveri), nel tentativo di sbarcare nei pressi di Argostoli, vengono fatte segno dai colpi delle artiglierie italiane. Una di queste viene affondata, l'altra danneggiata. Ma si tratta proprio di una parte dei mezzi che sarebbero stati utilizzati per lo sbarco a Corfù. Quando il 15 settembre le trattative con il Generale Gandin giungono alla rottura, appare chiaro al Comando tedesco che la priorità dell'azione si sposta su Cefalonia. Corfù può attendere. Mentre la prima divisione da montagna tedesca è impegnata a Cefalonia, il Comando di Corpo d'Armata continua a predisporre i piani di attacco a Corfù. Dal Generale Lanz giunge la conferma che "Il trattamento del presidio italiano di Corfù [va eseguito] secondo gli stessi punti di vista applicati nei confronti del presidio di Cefalonia". Nelle disposizioni ai soldati si preme soprattutto sul "tradimento italiano", giocando così sull'emotività dei reparti. Del resto l'operazione sarà proprio denominata "Verrat” (Tradimento) Lanz approva il piano di attacco il giorno 22 settembre, richiedendo in particolare l'intervento del X corpo aereo. Alle 13.00 del 23 settembre iniziano a Prevesa (Epiro – Grecia) le operazioni di imbarco, al comando del Capitano Dittmann, di un battaglione del 98°RGT da Montagna, di una sezione del 79°RGT Artiglieria da Montagna, di una compagnia del 54°BTG Pionieri da Montagna. Il gruppo principale, dopo aver effettuato delle manovre diversive per confondere la difesa italiana, raggiunge il suo obiettivo, la laguna di Corissia, sulla costa occidentale di Corfù, verso le ore 00.30 circa del 24 settembre. Poco dopo la testa di ponte è individuata dalla difesa italiana e fatta segno di tiri di artiglieria. Iniziano gli scontri a fuoco con reparti di fanteria italiana, mentre procedono gli sbarchi, nonostante il tiro dell'artiglieria italiana. Le batterie costiere vengono man mano eliminate. Entro le 4.00 i tedeschi hanno occupato le alture di Maltauna, che dominano l'intera zona, i reparti italiani si ritirano verso nord, negli scontri non si fanno prigionieri. Dopo le 5.00 inizia il rastrellamento del settore meridionale dell'isola; alcuni reparti italiani non danno segno di voler resistere, ma ad Argirades un gruppo ben organizzato prende di mira le due compagnie tedesche che stanno scendendo lungo la strada principale. L'intervento dell'aviazione mette a tacere ogni resistenza italiana: sul terreno rimangono 70 morti. Più a sud i soldati italiani sono sorpresi nei rifugi, dove cercano di proteggersi dagli attacchi aerei. Dopo ogni scontro non ci sono sopravvissuti. Qualche italiano diserta, del resto i tedeschi non lasciano alternative, chi si trova con le armi in mano viene eliminato. Verso sera il secondo battaglione del 98°RGT Cacciatori da Montagna ha raggiunto completamente i suoi obiettivi: il controllo di tutta la sezione meridionale di Corfù, tre Battaglioni italiani sono stati dissolti, con 500 soldati rimasti sul terreno; i prigionieri sono 1.500, considerati "disertori" dai tedeschi, e perciò non eliminati immediatamente. Il successo della prima fase delle operazioni permette ai tedeschi di completare rapidamente lo sbarco di un secondo gruppo, al comando del Capitano Feser, comprendente i reparti rimasti a Igumenitsa (Epiro – Grecia) del 99° Cacciatori da Montagna, oltre ad una sezione del 79°RGT Artiglieria da montagna. Le operazioni di sbarco si concludono però solo all'alba del giorno 25 settembre. Giungono sull'isola anche lo stato maggiore del gruppo di combattimento, al comando del Tenente Colonnello Remold, e il Generale Walter Stettner, comandante della 1^ Divisione da montagna. Al mattino due colonne tedesche, al comando dei Capitani Dittmann e Feser, iniziano le operazioni per spezzare la resistenza italiana, che può contare, oltre che sul fuoco dell'artiglieria, che rallenta l'avanzata tedesca, anche su alcuni aerei da attacco al suolo che creano qualche problema ai gruppi di assalto tedeschi. Sul passo di Stawros (Corfù) e sulle alture circostanti la difesa italiana ha approntato un'ultima linea di resistenza prima del capoluogo. Le postazioni italiane sono annientate una dopo l'altra dalle truppe di assalto tedesche, che prendono così possesso delle alture e delle postazioni fisse. Dopo i combattimenti non ci sono sopravvissuti tra gli italiani, alcuni reparti cominciano a dar segno di cedimento: i tedeschi vedono aumentare i soldati che si arrendono dopo aver consegnato "spontaneamente" le armi, mentre gli ufficiali di più alto grado ripiegano verso il capoluogo. La cittadina di Corfù, tuttavia, è ancora difesa da una linea di fortificazioni italiane, disposta a sudest del centro abitato, con l'appoggio di un'efficace difesa antiaerea. Mentre il Capitano Feser ha il compito di aggirare le difese nemiche verso nord, per impedire lo sganciamento dei reparti italiani, sono messi in azione le unità di artiglieria pesante che concentrano il fuoco sulla cittadella della capitale. Il gruppo Dittmann, a questo punto, attacca la linea difensiva italiana, che viene sopraffatta dopo un violento scontro a fuoco. Poco dopo "sulla cittadella di Corfù fu issata la bandiera bianca". L'ultima comunicazione italiana da Corfù è delle 16.20 "Abbiamo distrutto tutte pubblicazioni segrete. Ci apprestiamo a distruggere radio". Alle 17.00 del 25 settembre, i tedeschi entrano in città. Oltre 5.000 soldati italiani depongono le armi, ovvero i reparti della divisione Acqui e quelli provenienti dalla terraferma. Tra gli italiani vi sono oltre 600 caduti e circa 1.200 feriti. Verso nord continuano, nel frattempo, le operazioni di rastrellamento degli ultimi reparti rimasti in azione. Verso le 23.00, a Skriperon, i tedeschi catturano il comandante dell'isola, il Colonnello Lusignani, e l'intero stato maggiore. Dopo trattative, Lusignani dà l'ordine a tutte le truppe italiane di deporre le armi. Ha così termine la battaglia di Corfù.
Nel resoconto del Generale Stettner, si dà conto del bottino ingente, sufficiente ad equipaggiare otto battaglioni di fanteria, si parla di "700 nemici morti", senza distinguere tra caduti in combattimento e fucilati, non si parla di "prigionieri", ma di circa 10.000 "disertori", cifra che risulta esagerata rispetto alla realtà. Tuttavia, il giorno 28 settembre, il Generale Lanz richiede al Comando supremo del Gruppo armate E quali misure di ritorsione avrebbe dovuto adottare contro i militari italiani; da Löhr, questa volta, giunge l'indicazione di soprassedere, considerando che gli Ufficiali direttamente responsabili dello smacco subito dopo l'armistizio, con la cattura dei militari tedeschi poi trasferiti in mano inglese, erano già stati fucilati. In effetti Lanz aveva già provveduto ad applicare le disposizioni sulla fucilazione degli ufficiali italiani a Corfù. Il 27 settembre, a mezzogiorno, il Colonnello Lusignani, il Colonnello Bettini, della Divisione “Parma”, e altri 19 Ufficiali, sono trattati secondo l'ordinanza del Führer. I tedeschi hanno perduto circa 200 uomini, 18 cacciabombardieri e cinque mezzi navali, oltre al primo gruppo di prigionieri consegnati agli inglesi.
Dopo 12 giorni di attacchi delle forze preponderanti aeree e terrestri tedesche le truppe italiane furono sopraffatte e gli ufficiali italiani, fra cui il tenente Natale Pugliese e lo stesso comandante dell'isola Luigi Lusignani, furono fucilati e i loro corpi gettati in mare dalla fortezza di Corfù. In seguito i tedeschi tentarono di trasportare i prigionieri italiani sopravvissuti in Germania, dal porto di Corfù, utilizzando la motonave “Mario Roselli”; La motonave Mario Roselli fu una nave da carico protagonista di una delle più gravi tragedie delle truppe italiane vittime della seconda guerra mondiale, rappresentata dall'eccidio di Cefalonia e di Corfù. Il 9 ottobre 1943 la motonave Mario Roselli giunse in rada a Corfù per imbarcare numerosi prigionieri italiani, circa 5.500 militari, che nei giorni prima erano stati catturati negli scontri tra i tedeschi e la resistenza, organizzata dagli stessi militari italiani. Le operazioni di imbarco iniziarono all'arrivo della nave e si protrassero per tutta la notte tra il 9 ed il 10 ottobre; i prigionieri venivano trasbordati da riva alla nave tramite piccoli motoscafi. Ad imbarco quasi completato, alle ore 7:15 del 10 ottobre, venne avvistato un aereo alleato, che immediatamente attaccò la nave ed i motoscafi. Una bomba centrò con tragica precisione un motoscafo, pieno di prigionieri, ed un'altra, passando da un boccaporto aperto, cadde direttamente nella stiva della nave, gremita di italiani, ed esplose, causando una terribile strage e lo sbandamento della nave sulla dritta a causa dell'imbarco di acqua. Molti prigionieri sulla Roselli, non coinvolti nell'esplosione, tentarono di salvarsi gettandosi in mare, per poi affogare poco dopo. Il mare intorno alla nave si riempì quindi di cadaveri, rendendo l'idea di quanta sofferenza ed orrore si verificarono in questo tragico bombardamento su prigionieri inermi; sono state calcolate 1.302 vittime. I prigionieri a terra, capendo la gravità ed il pericolo della situazione, fecero un tentativo di fuga nelle campagne circostanti, inseguiti dai tedeschi che avevano aperto un fitto fuoco sugli inseguiti; alcuni di questi ultimi, nonostante l'odio dei greci per l'occupazione italiana, vennero aiutati e nascosti dalla popolazione, scampando a morte certa. I superstiti a bordo della nave vennero sbarcati, e la nave, gravemente sbandata, venne abbandonata in rada dove si trovava al momento del bombardamento. Il giorno dopo vi fu un nuovo attacco aereo, che causò il definitivo affondamento della Mario Roselli.
Sul foglio matricolare di IERACI Vincenzo viene trascritta come data di cattura il 20.09.1943, ma probabilmente è stato catturato dopo il 23 settembre. IERACI viene quindi fatto prigioniero e deportato in Germania in speciali campi. I trasporti verso la Germania, avvennero in condizioni terribili e costarono la vita a migliaia di prigionieri italiani, periti in seguito all'affondamento di vari piroscafi colpiti da unità di superficie e da sommergibili delle forze alleate.
L’obiettivo di Hitler era quello di eliminare dallo scacchiere della guerra uomini che, eventualmente schierati a fianco degli Alleati, avrebbero potuto creare problemi alle sue armate, nello stesso tempo, tentava di recuperare braccia, forza lavoro, da impiegare nell’industria tedesca.
Lo stato maggiore della Wehrmacht appoggiò il proposito di Speer, il ministro degli Armamenti, di impiegare il più rapidamente possibile i prigionieri italiani come forza lavoro, soprattutto a fronte della necessità di reclutare un sempre maggior numero di lavoratori tedeschi da inviare al fronte per realizzare, secondo le parole del ministro della propaganda Goebbels, la “guerra totale” che aveva come obiettivo la vittoria finale della Germania.
Il 20 settembre 1943, dopo la liberazione di Mussolini e poco prima della proclamazione del nuovo stato fascista (la Repubblica Sociale Italiana), Hitler ordinò di trasformare i prigionieri italiani in “internati militari”. Il mantenimento dello status di prigionieri di guerra per gli internati militari avrebbe di fatto significato trattare alla stregua di una potenza nemica lo stato che Mussolini si apprestava a proclamare. Quindi I nostri soldati divennero IMI (Internati Militari Italiani), e fu negata la denominazione di prigionieri di guerra e i relativi diritti, garantiti dalla Convenzione di Ginevra. Al momento della proclamazione dell'Armistizio, l'Italia e la Germania non si potevano giuridicamente considerare in guerra, atteso che la dichiarazione di Guerra alla Germania, fu formalizzata dal governo Badoglio solo il 13.10.1943: per questo motivo, i soldati italiani, furono definiti giuridicamente, dai tedeschi "franchi tiratori", quindi sottoposti a un regime legale non convenzionale. Dopo la creazione della Repubblica Sociale Italiana, i tedeschi, non intendendo riconoscere al Regno d'Italia alcuna legittimità nel dichiarare guerra al proprio Paese, decisero di confinare gli internati militari italiani, che non prestarono giuramento alla Repubblica Sociale, per rimanere fedeli a quello fatto al Re, in questi campi di concentramento e di lavoro.
IERACI Vincenzo, viene liberato solo in data 08.05.1945, probabilmente era detenuto presso il lo Stalag 6° nei pressi di Remscheid (ora nel distretto di Düsseldorf), non si esclude la possibilità che nel corso della prigionia, sia stato trasferito in più Stalag (campo). Dai documenti in possesso della famiglia (riportato nella pagina precedente ndr) si evince che la prima cosa che gli è stata data dopo la fine della prigionia è un pezzo di sapone.
In data 31.08.1945 rimpatriato dalla prigionia e giunto al centro di alloggio di Verona.
Il 17.09.1945 si presenta al Distretto Militare di Catanzaro e inviato in licenza straordinaria di rimpatrio di gg. 60.
Il 20.11.1945 viene collocato in congedo illimitato.
Dopo la guerra, si dedica anima e corpo alla famiglia, si sposa con FARAGO’ Concetta, ha nove figli; ma il 26.06.1966 la leucemia ha il sopravvento su di lui, 16 giorni dopo la nascita dell’ultimo figlio Enrico.